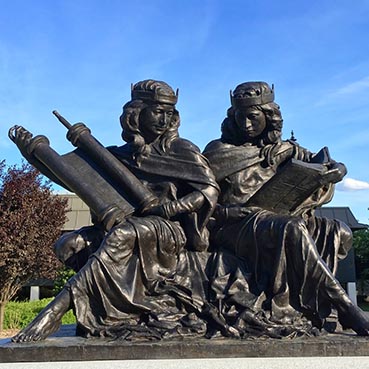Attualità, 22/2007, 15/12/2007, pag. 784
A cent'anni dalla condanna del modernismo: scienza, storia e critica biblica
P. Stefani
Negli ultimi anni si è riproposto nel dibattito culturale il tema del rapporto tra scienza e fede, dal versante sia della relazione tra ermeneutica biblica e metodo storico, sia di quella tra credenze religiose e scienze naturali.
Su entrambi i fronti far proprio il criterio della distinzione degli ambiti comporta trovare una via per cogliere il senso proprio – per esempio – della prima narrazione della creazione, e insieme consentire all’indagine cosmologica di operare secondo un’epistemologia a essa propria, senza prestabilire a priori che la ricerca scientifica debba infine aprirsi a Dio, opzione di ordine metafisico e non scientifico. L’unica richiesta che si può avanzare alle scienze è di rinunciare all’illegittima pretesa di assolutizzare il proprio sapere, autolimitazione cui peraltro le scienze stesse devono pervenire applicando un rigoroso discorso metodologico ed epistemologico.
L’analisi di Gian Luigi Prato sulle cosmologie bibliche e quella di Piero Stefani (p. 784) su scienza della natura, storia e teologia offrono una lettura di come la ricerca in ciascun ambito scientifico debba perseguire spiegazioni legate al proprio statuto epistemologico, senza avanzare l’esigenza di assolutizzarle ma anche senza dover rispondere a preoccupazioni teologiche che non sono loro proprie.
La lettura dell'articolo è riservata agli abbonati a Il Regno - attualità e documenti o a Il Regno digitale.
Gli abbonati possono autenticarsi con il proprio codice abbonato. Accedi.