Camminare «nella luce del Signore»
Con questa domenica entriamo nel tempo liturgico dell’Avvento. Un tempo forte che per quattro settimane ci accompagnerà a riflettere sulla fine della storia umana.
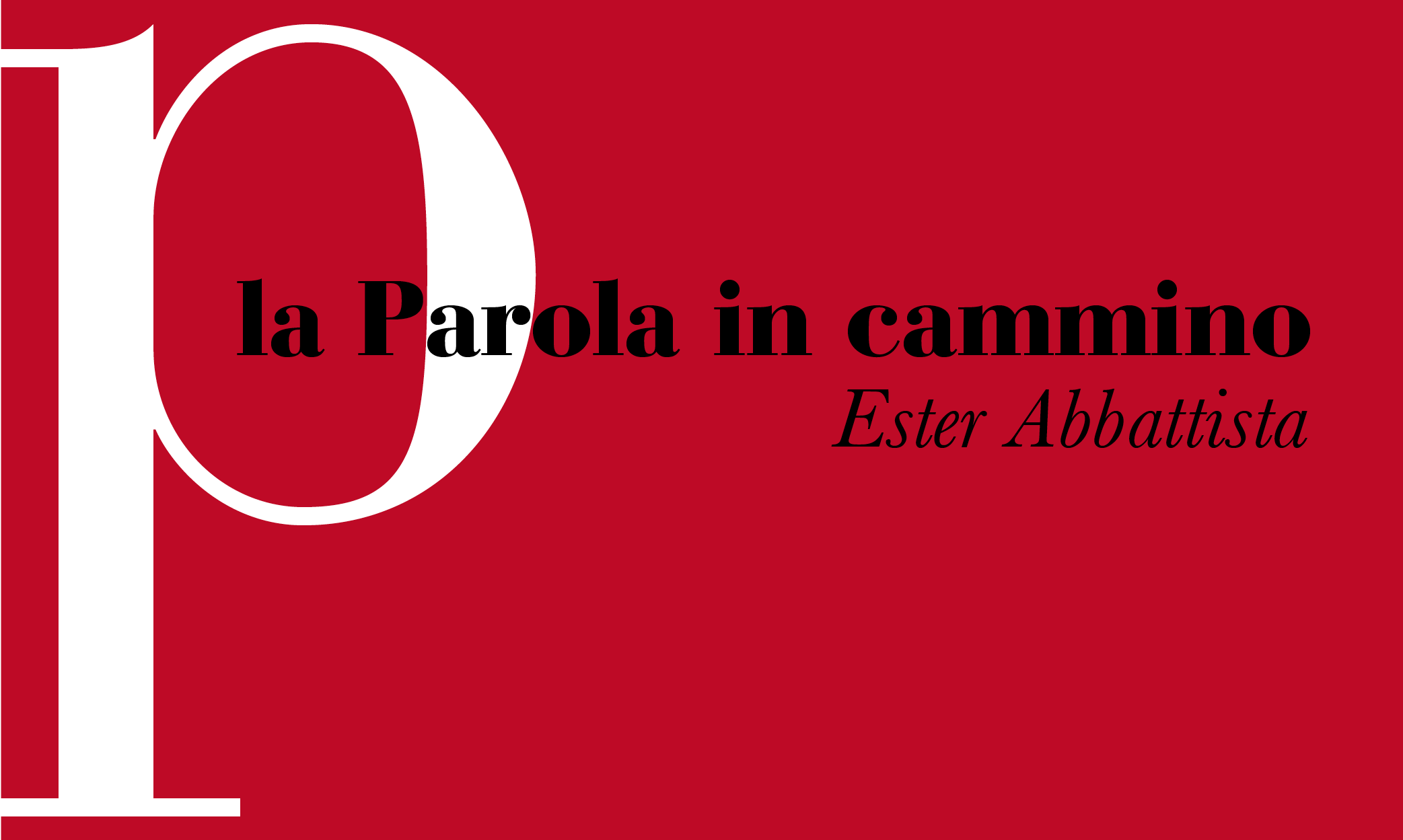
I domenica di Avvento
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Con questa domenica entriamo nel tempo liturgico dell’Avvento. Un tempo forte che per quattro settimane ci accompagnerà a riflettere sulla fine della storia umana, sul suo compimento che, secondo la fede ebraica e cristiana, culminerà con la venuta definitiva del Messia.
Contrariamente, quindi, a quanto di solito si pensa, l’Avvento non è la preparazione al Natale, ma è ciò che «succede» al Natale, dato che, per i cristiani, la prima venuta del Messia è segno, speranza e fondamento di quello che sarà «alla fine dei giorni».
Una «fine dei giorni» annunciata dai profeti, come nella prima lettura, dove secondo le parole di Isaia Gerusalemme-Sion sarà la meta di arrivo di tutti i popoli, il luogo in cui si manifesterà la pienezza della rivelazione: «Poiché da Sion uscirà la Torah e da Gerusalemme la parola del Signore».
La fine dei giorni quindi è segnata dalla manifestazione ultima di quella «Parola del Signore», compimento pieno della Torah, che sarà consegnata, come in un nuovo Sinai, a tutti i popoli e le nazioni che riconosceranno il Dio di Israele e, alla fine, di tutte le genti.
La pienezza poi di questa rivelazione sarà il segno non solo del dono dato a tutti, ma anche della capacità di tutti di accogliere quel dono, ognuno mantenendo la propria caratteristica e diversità. Diversità e alterità che non saranno più causa di inimicizia o di guerre, ma possibilità di armonia, di pacifica convivenza, di pienezza di vita, ovvero, detto in ebraico, di Shalom: «Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra». Tutto questo – dice il profeta – è il futuro che ci attende, a cui tutta l’umanità anela, e riconoscerlo significa mettersi in cammino, un cammino particolare, che si può compiere solo alla «luce del Signore».
L’invito a «camminare», quindi, con lo sguardo rivolto verso la «luce», ovvero in ascolto della Parola del Signore, è la vera dimensione di attesa, di «veglia» che Gesù suggerisce nel Vangelo. Il contrasto è dato appunto da chi è «vigile» e chi non lo è, perché solo chi è «desto» sarà capace di attendere e riconoscere la «venuta» del «Figlio dell’uomo».
Ci sono qui due punti che vanno messi a fuoco. Da una parte l’esempio della vita «al tempo del diluvio», e dall’altra l’espressione «Figlio dell’uomo».
La scena che Gesù evoca «nei giorni che precedettero il diluvio» è quella di una normale vita quotidiana, direi di un’esistenza umana persino tranquilla nella sua normalità: «Mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito». Ma è proprio questa «tranquilla normalità» ciò che permette di «non accorgersi di nulla», di vivere in un certo senso «addormentati», immersi nel proprio piccolo mondo – non solo «antico» ma di ogni tempo –.
Si può vivere un’intera esistenza senza «accorgersi di nulla», rincorrendo le proprie mete, desiderando e/o realizzando i propri successi, e sperando di rimanere lontani da tutto ciò che avviene di male, siano queste malattie, catastrofi naturali, guerre o qualsiasi altra calamità. Ma questa «sonnolenza» risulta essere letale, e quando l’acqua del diluvio ormai si presenta nella sua forza inarrestabile è ormai troppo tardi.
Tardi per che cosa? Certamente non per un altro «diluvio», ma per riconoscere la «visitazione» di Dio, la venuta del «Figlio dell’uomo». Ora questa espressione – «Figlio dell’uomo» – è una citazione diretta del testo di Daniele 7,13-14: «Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto», segno che vi era in Israele anche l’attesa di un Messia con caratteri divini.
Nel Vangelo di Marco, alla domanda del sommo sacerdote Gesù risponderà proprio citando Daniele 7: «Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: “Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?”. Gesù rispose: “Io lo sono! E vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del cielo”» (Mc 14,61-62).
Se dunque a Natale celebriamo la nascita del Messia, la sua prima venuta, è con l’Avvento che l’attesa della sua definitiva venuta si rinsalda e si apre alla speranza certa. Ma perché allora l’Avvento precede il Natale? Il Natale fa memoria di un evento storico, avvenuto in un determinato tempo e luogo, mentre l’Avvento è la dimensione costante che abbraccia tale evento in un prima e in un dopo, è ciò che dovrebbe scandire i nostri giorni, dal primo all’ultimo, perché ogni giorno è carico di attesa, di speranza, di pienezza: «Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. (...) Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
L’insegnamento dell’Avvento è vivere l’attesa come habitus, vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo; è imparare a valutare e affrontare ogni cosa a partire dalla sua fine per coglierne il suo vero peso e valore; è l’invito che troviamo nel Sal 90,12: «Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio».
Georges de La Tour, Maddalena penitente, 1625-1650. New York, Metropolitan Museum of Art.
