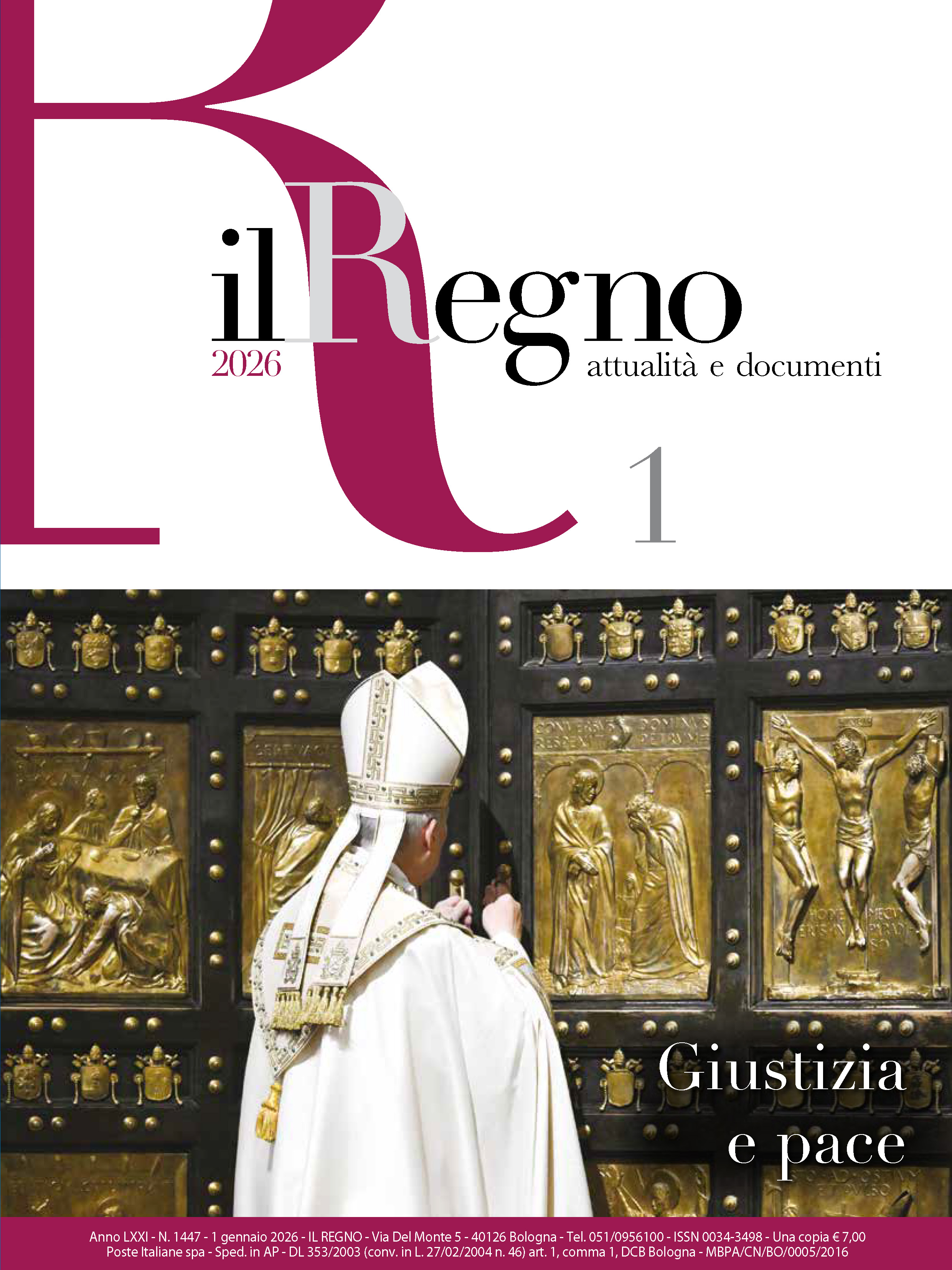Teologia dell'ospitalità
Questo saggio del teologo Alberto Frigerio, professore incaricato di Etica della vita presso l’Istituto superiore di scienze religiose di Milano, si muove su più livelli. Dal lato antropologico l’autore lega l’allentamento del tradizionale valore dell’ospitalità nella modernità occidentale alla «crisi dell’universale cristiano» e allo sviluppo di una «visione monologica della soggettività», indicando per converso la «soggettività relazionale» di Lévinas e Ricoeur come base di una «filosofia dell’accoglienza ospitale». Sul versante biblico, ci si sofferma su Israele come «emblema dell’umanità straniera ospitata da Dio»: l’atteggiamento ospitale è dunque «imitazione dell’ospitalità divina». Nel Nuovo Testamento, l’ospitalità è accoglienza di Dio (theoxenia) ed esperienza dell’accoglienza trinitaria: nella vita della Chiesa diventa prassi istituzionalizzata.
Viene poi introdotto il concetto di politiche migratorie coi suoi modelli principali, oggi stretti tra la necessità di favorire l’inclusione degli immigrati e di mantenere la coesione sociale. La dottrina sociale della Chiesa afferma lo ius migrandi, ma lo condiziona al «perseguimento del bene comune», peraltro da declinare in senso universalistico. Le conclusioni evidenziano l’urgenza di «una legislazione internazionale» e di un’integrazione basata sulla «comunione nella diversità», alla ricerca di principi condivisi. L’immigrazione consente alla Chiesa di vivere pienamente la cattolicità, l’ecumenicità e il dialogo interreligioso.
Un excursus è dedicato al «carattere tipicamente femminile dell’ospitalità», che trova pienezza in Maria.
La lettura dell'articolo è riservata agli abbonati a Il Regno - attualità e documenti o a Il Regno digitale.
Gli abbonati possono autenticarsi con il proprio codice abbonato. Accedi.