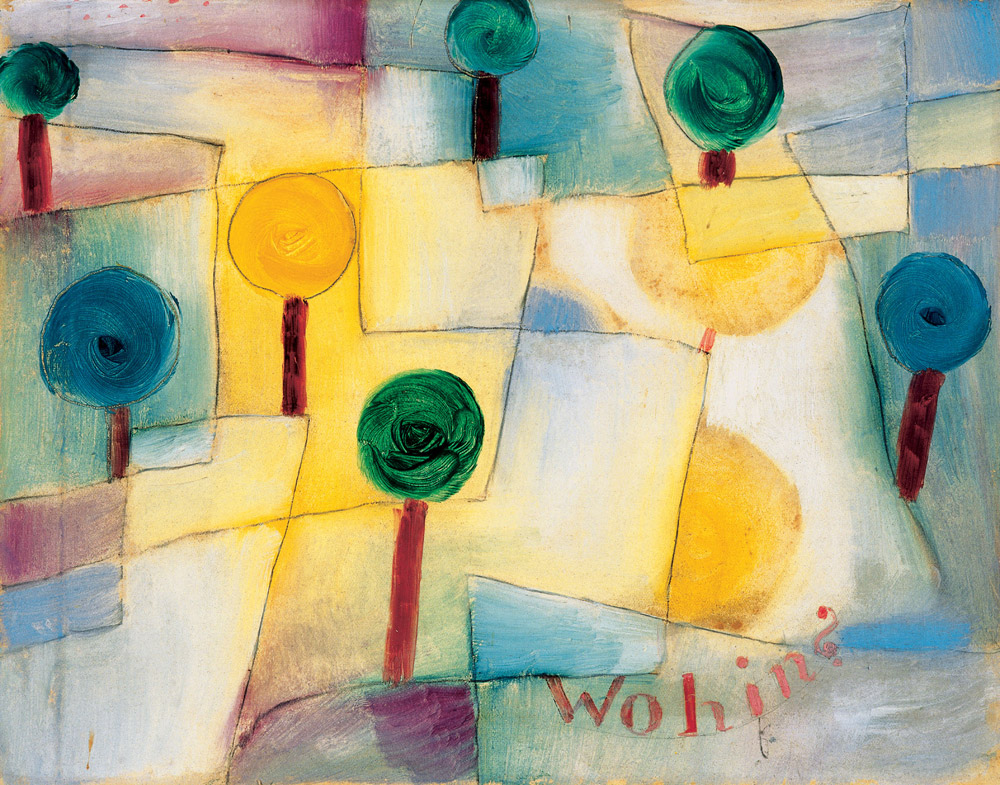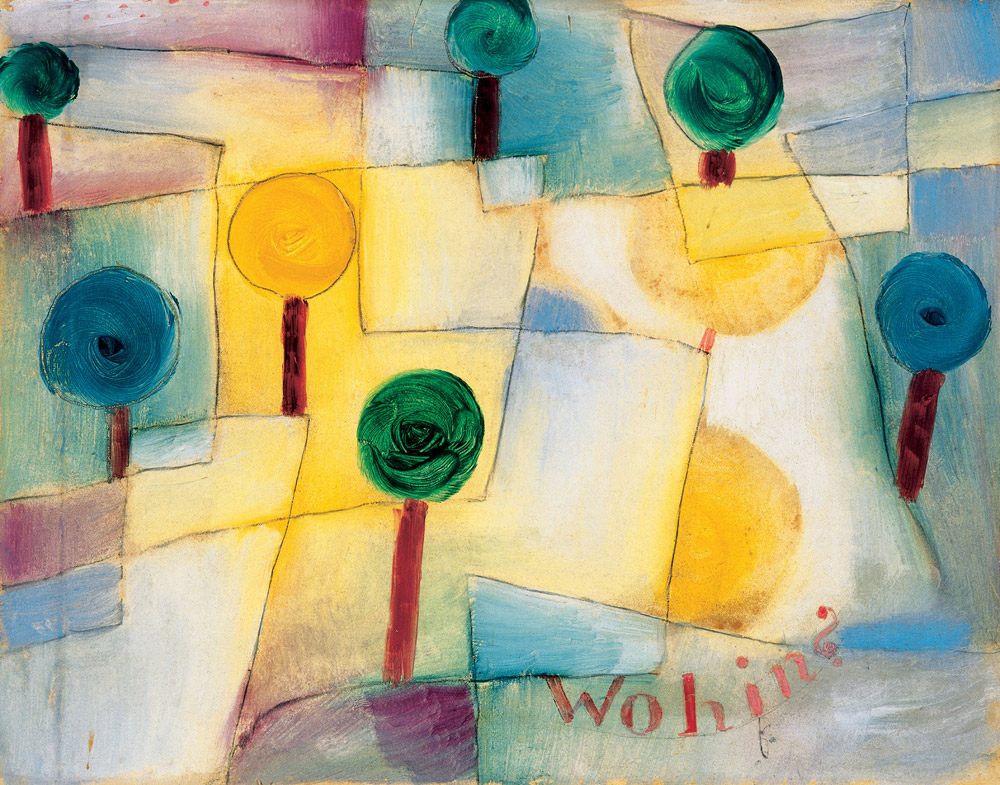Il ritorno e la terra. Radici e genesi del sionismo

Nel XIX secolo sorsero due tendenze inedite all’interno dell’ebraismo. Si trattò di orientamenti reciprocamente incompatibili, entrambi però accomunati dal fatto d’essere debitori nei confronti di una cultura dominata dall’idea di progresso: l’avvenire sarebbe stato meglio del presente.
Nella loro polarizzazione estrema, i due filoni sono definibili nei seguenti termini: da un lato, vi fu la trasformazione dell’ebraismo in pura religione etica sprovvista di ogni connotato nazionale; dall’altro, vi fu l’affermazione dell’idea nazionale secondo la quale il popolo ebraico, che viveva ovunque come una minoranza, conseguisse una collocazione territoriale unitaria nella quale potesse autogovernarsi.
La prima alternativa trovò un’espressione particolarmente esplicita in uno dei simboli dell’ebraismo riformato americano: la Pittsburgh Platform 1885. Vi si legge: vediamo «nella moderna era di universale cultura dello spirito e dell’intelletto l’approssimarsi della realizzazione della grande speranza messianica per l’instaurazione del regno di verità, giustizia e pace tra tutti gli uomini. Ci reputiamo non più una nazione, bensì una comunità religiosa e perciò non aspettiamo né un ritorno in Palestina, né un culto sacrificale sotto i figli di Aronne, né la restaurazione di ogni legge relativa allo Stato ebraico».
L’altra opzione fu rappresentata, va da sé, dal sionismo nazionalista.
Entrambe le antitetiche visioni implicavano il definitivo abbandono della prospettiva tradizionale, cuore della secolare esistenza ebraica nella diaspora. Quel particolare stile di vita e di pensiero trovava riscontro nella dottrina dei cosiddetti «tre giuramenti». Nel Cantico dei cantici vi è una triplice ripetizione del versetto: «Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle o per le cerve dei campi: non destate, non scuotete, dal sonno l’amore, finché non lo desideri» (Ct 2,7; 3,5; 8,4).
Sulla scorta di questa specifica lettura, le figlie di Gerusalemme simboleggiano le genti detentrici del potere nelle aree in cui erano stanziate le comunità ebraiche. Non bisogna ridestare l’amato, vale a dire il Messia, prima che sia l’ora; quindi occorreva astenersi dall’affrettare impropriamente i tempi: «Perché questi tre giuramenti? Uno affinché Israele non salga il muro [o come un muro], uno perché il Santo, benedetto Egli sia, fece giurare a Israele di non ribellarsi alle nazioni del mondo e uno perché il Santo, benedetto Egli sia, fece giurare gli adoratori delle stelle di non opprimere troppo Israele» (Talmud babilonese, Ketubbot, 111a).1
Dio fece giurare, da un lato, al popolo ebraico di non salire in massa in terra d’Israele e quindi di vivere sotto il Governo altrui e, dall’altro, alle genti («gli adoratori delle stelle», cf. Dt 4,19) di non spingersi troppo in là nell’umiliare i figli d’Israele.
Il sionismo politico
Per quanto non manchino, all’interno dell’ebraismo anche attuale, piccole minoranze antisioniste che ritengono ancora valida questa prospettiva,2 è innegabile che due avvenimenti succedutisi negli anni Quaranta del XX secolo abbiano, in sostanza, sciolto il popolo ebraico dai tre giuramenti.
Con la Shoah gli «adoratori della svastica» hanno travalicato ogni limite posto all’oppressione; mentre, con la nascita dello Stato d’Israele (1948), la bandiera con la stella di Davide è stata piantata in una terra collocata oltre il muro. Tuttavia a fine Ottocento entrambi gli avvenimenti erano lungi dal realizzarsi. Ciononostante, all’interno stesso dell’ebraismo, la visione tradizionale aveva già subito duri colpi: la convinzione dei riformati aveva consegnato l’oppressione agli archivi della storia, mentre il sionismo aveva deciso di scavalcare il muro dell’esilio senza attendere il Messia; per farlo occorreva una precondizione: essere convinti di costituire una nazione.
Nel 1882 nel suo pamphlet Auto-emancipazione, l’ebreo russo Leon Pinsker scriveva che «gli ebrei sono dappertutto e nessun luogo è la loro casa. I popoli non hanno a che fare con la Nazione ebraica, ma sempre e soltanto con gli individui ebrei. Gli ebrei non sono una nazione, perché manca loro quel preciso carattere nazionale distintivo che posseggono tutte le altre nazioni, carattere determinato unicamente dalla convivenza in un paese unico, sotto un medesimo Governo».3
Come raggiungere questa meta? Allorché il risveglio nazionale ebraico assunse la forma di sionismo politico si creò una situazione inestricabilmente legata all’età del colonialismo. Senza il consenso altrui era inimmaginabile mettere in moto il processo di una società a maggioranza ebraica in grado d’autogovernarsi.
Quando, nel 1896, Theodor Herzl scrisse Der Judenstaat era ben consapevole di tutto ciò. Si legge in un passaggio del suo opuscolo: «La Palestina è la nostra patria storica, che ci resterà sempre nel cuore. Questo nome da solo sarebbe un segnale di adunata straordinariamente toccante per il nostro popolo. Se sua maestà il sultano ci concedesse la Palestina, ci potremmo impegnare, per sdebitarci, a risistemare le finanze della Turchia. In favore dell’Europa costruiremmo là una parte del vallo per difenderci dall’Asia, costituendo così un avamposto della cultura contro le barbarie».4
L’idea del ritorno
Nella Torah scritta (Pentateuco) la terra d’Israele viene chiamata terra di Canaan. Non si tratta di una qualifica occasionale. La scelta d’indicare quel territorio con un nome altrui è funzionale a una narrazione dapprima incentrata su una futura conquista espressa attraverso il duro e sacrale linguaggio dello sterminio (cherem; cf. ad esempio Dt 7,1-2), poi descritta, specie nel libro di Giosuè, attraverso il compimento di quanto preannunciato.
A fine Ottocento le condizioni storico-culturali non consentivano al movimento sionista d’ispirarsi al linguaggio della conquista di un territorio altrui. Era più conforme guardare a un altro topos biblico, quello legato all’idea del ritorno; un processo che ha alle proprie spalle l’esistenza di un precedente allontanamento. Ritornare non equivale a entrare: «Il Signore, tuo Dio, ti ricondurrà nella terra che i tuoi padri avevano posseduto e tu ne riprenderai possesso. Egli ti farà felice e ti moltiplicherà più dei tuoi padri» (Dt 30,5).
Rispetto alla terra, in epoca moderna, ciò fece sì che l’ideologia fondante fosse quella del ritorno e non già quella della conquista. Ciò ha comportato e comporta un perenne problema di come relazionarsi con l’«altro» residente in una terra considerata propria. L’idea del ritorno è, in ogni caso, facilmente predisposta a essere secolarizzata in senso nazionalistico.
La conquista di una terra altrui (Canaan), per essere legittimata, necessita del presupposto di un sedicente giuramento divino (cf. Dt 26,3); di contro, la prospettiva del ritorno trova sostegno in un antico possesso. Quando si torna a casa propria («national home», per dirla con la Dichiarazione Balfour) e ci si accorge che è abitata da altri, questi ultimi vengono considerati o estranei da allontanare od ospiti da accogliere (e alla lunga da sopportare) o, nel migliore dei casi, persone con cui convivere.
Nel XX secolo, dopo la nascita dello Stato d’Israele, l’idea di ritorno assunse una dimensione giuridica in una legge che, approvata nel 1950 e integrata sia nel 1954 sia nel 1970, è chiamata appunto «del ritorno». Il suo primo articolo recita: «Ogni ebreo ha il diritto d’immigrare in Israele». Nel complesso la legge esemplifica assai bene il carattere ebraico dello Stato; essa è stata anche uno dei fattori che obbligò a definire legislativamente chi è ebreo (il che, dopo aspri dibattiti, avvenne nel 1958). In Israele la legge dello Stato definisce chi va considerato ebreo; operazione che in Europa, con tutt’altro spirito, venne attuata dalle legislazioni razziali ma che resta improponibile all’interno di qualsiasi Stato liberal-democratico.
Come mostra il biblico libro di Esdra, l’idea del ritorno alla propria terra può comportare delle espulsioni (allora si trattò delle mogli straniere e dei figli delle coppie miste, cf. Esd 9s), mentre rende impensabile che, in futuro, sia consentito agli espulsi di ritornare ai loro antichi possessi. Le conseguenze della nakba palestinese, lungi dall’essere riconducibili a libri biblici, parlano l’aspro linguaggio della realtà. È storia pluridecennale resa inestricabile a causa della natura ebraica dello Stato d’Israele.
Si tratta comunque di un’altra vicenda rispetto a quanto sta avvenendo a Gaza, nei confronti della quale il linguaggio di uno sterminio privo di ogni aura sacrale appare assai più corrispondente ai fatti di quello di espulsioni o emarginazioni legate all’idea del ritorno.
1 Fondamentale su questo tema l’Appendice «Che non salgono il muro», in A. Ravitzky, La fine svelata e lo Stato degli ebrei, Marietti, Genova – Milano 2007, 279-312, in cui, a fronte della sottovalutazione sionista, si dimostra la rilevanza storica del tema dei «tre giuramenti». Cf. anche M. Giuliani, Eros in esilio. Letture teologico-politiche del Cantico dei Cantici, Edizioni Medusa, Milano 2008.
2 In questo novero rientrano, ad esempio, i chassidim di Satmar, gruppo che rappresenta principalmente ebrei ungheresi e romeni radicalmente antisionisti. Fondati da rav Yoel Teitelbaum (1887-1979), attivi ancora oggi, hanno il proprio quartier generale nello Stato di New York e rifiutano, non riconoscendo la legittimità di quello Stato, d’installarsi in Israele.
3 L. Pinsker, Auto-emancipazione. Appello di un ebreo russo ai suoi fratelli, Il Melangolo, Genova 2004, 40.
4 T. Herzl, Lo Stato ebraico, Il Melangolo, Genova 2003, 42.