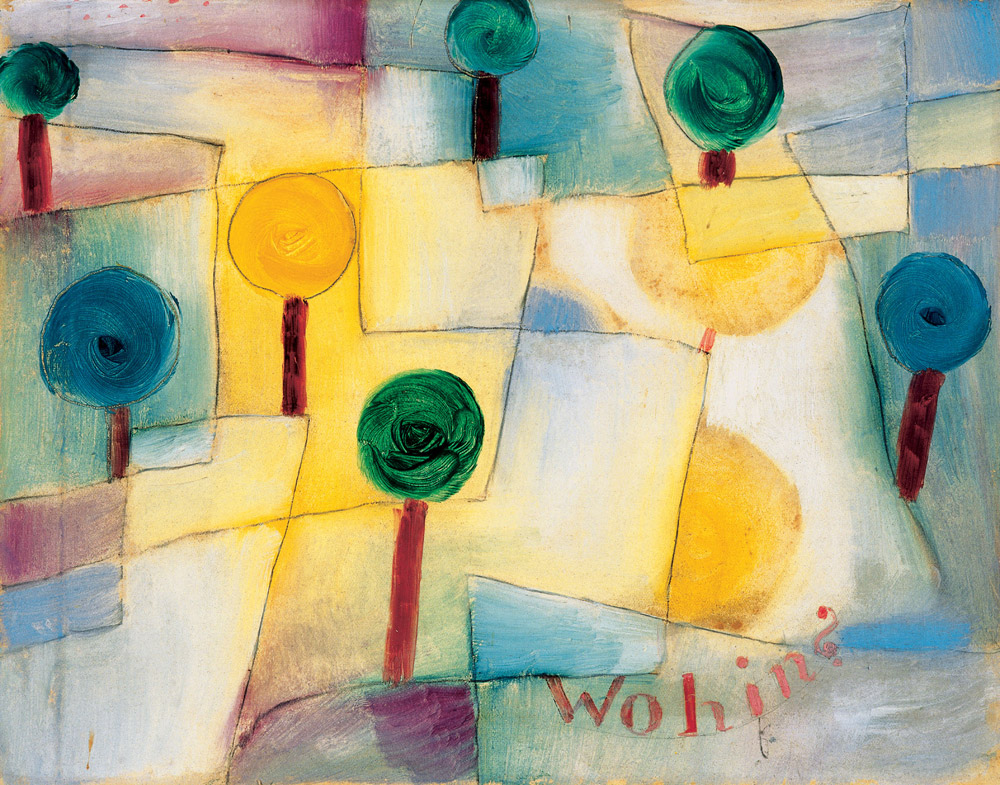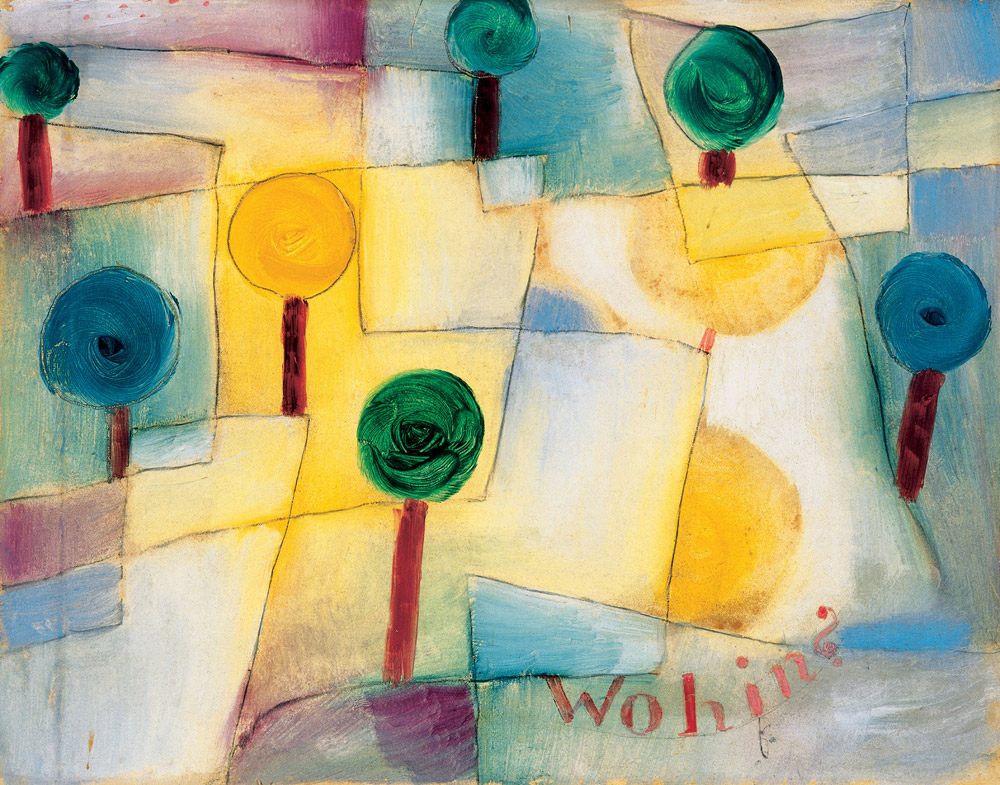In principio era la traduzione
Origine e comprensione del testo
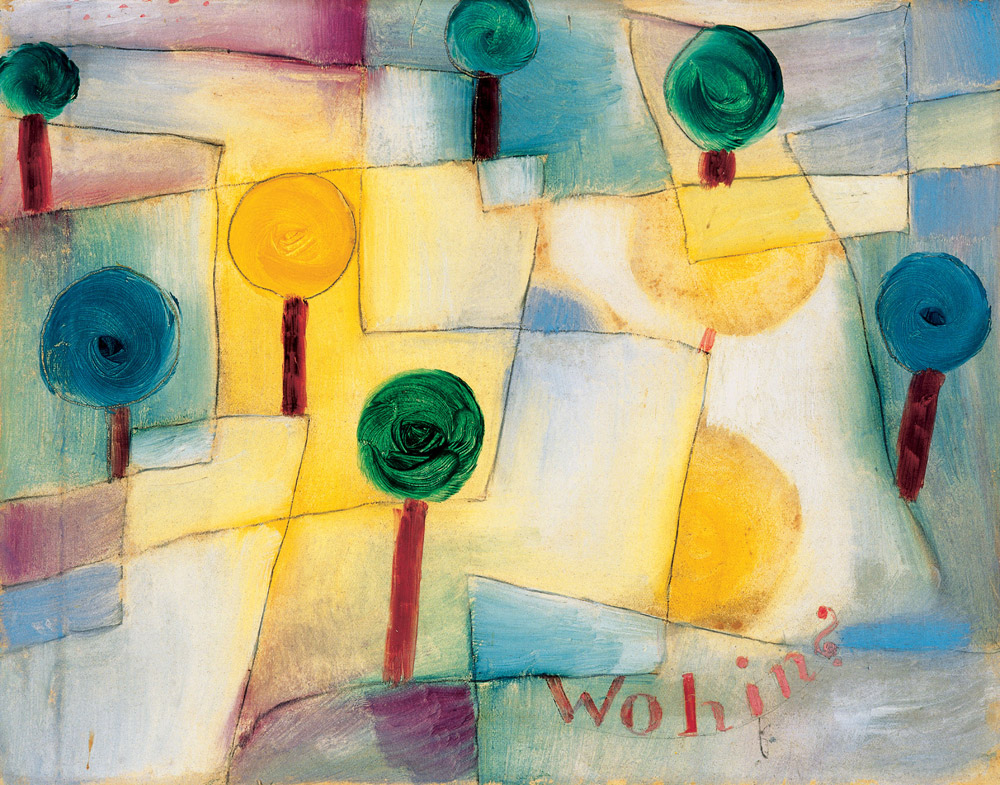
Le tradizioni religiose dotate di testi sacri si trovano di fronte a un bivio:1 conservarli, trasmetterli e leggerli nella loro lingua originale oppure servirsi di traduzioni? Nel primo caso sono i fedeli a dover apprendere una lingua, quasi sempre non più loro; nel secondo è il libro rivelato a doversi conformare all’idioma dei vari gruppi umani. Questa duplicità conosce alcune eccezioni.
Ciò avviene in senso forte quando l’originale è perduto e, in senso meno estremo, allorché è privato di forza normativa. La prima alternativa trova una calzante esemplificazione nel Libro di Mormon. Nel 1823 Joseph Smith affermò d’aver ricevuto dall’angelo Moroni l’indicazione di dove rinvenire alcune tavole d’oro scritte in egiziano riformato. Il loro contenuto fu tradotto. Undici testimoni sostennero d’aver visto le tavole, poi restituite da Smith all’angelo nel 1838.
Nel frattempo, nel 1830 era stato pubblicato The Book of Mormon: An Account Written by the Hand of Mormon upon Plates Taken from the Plates of Nephi. Non è dato risalire al di là della traduzione inglese. La seconda alternativa è esemplificata dall’ufficializzazione tridentina della Vulgata che «deve essere ritenuta come autentica nelle lezioni pubbliche, nelle dispute, nella predicazione e spiegazione».2
L’atto di ricavare da un testo sacro la linfa per la vita religiosa di un popolo implica la comprensione di quanto vi è scritto. Il problema è antico, attestato già nella storia ebraica post-esilica. Da un lato vi fu il bisogno di conservare il Libro in quella che era ritenuta la sua immutabilità lessicale; dall’altro emerse l’esigenza dell’assemblea di comprendere quanto veniva proclamato.
Accanto alla volontà di conformarsi all’originale (o quanto meno a quello che fu giudicato tale) e al ricorso a una traduzione, in Israele emerse una terza via (fermo restando che l’ebraismo conosce anche le precedenti due opzioni). La scelta intermedia trova riscontro nel Targum. In realtà, l’affermazione vale appieno solo per la fase più antica, quando l’atto di tradurre costituiva un’attività orale, mentre cessa d’essere pertinente allorché si giunse a codificazioni scritte destinate, col passare del tempo, a non essere più corrispondenti alla lingua parlata.
In senso specifico, il termine Targum indica la versione-parafrasi del testo sacro compiuta nel corso delle riunioni sinagogali. Stando a un passo talmudico (dotato, probabilmente, di qualche attendibilità storica), l’esempio più antico risalirebbe alla grande proclamazione della Legge svoltasi a Gerusalemme davanti alla porta delle acque coordinata da Esdra (cf. Ne 8).
Secondo questa interpretazione (cf. Talmud babilonese, Meghillah, 3a), «lessero il libro della Legge a sezioni» (Ne 8,8) si riferisce al testo ebraico; «spiegandone il significato» allude alla sua traduzione in aramaico, la lingua allora parlata dal popolo. Non si abbandona né il testo né la sua lingua, tuttavia la comprensione è affidata a una versione-interpretazione aramaica.
Il lettore venne così affiancato da un traduttore, la cui attività, secondo le fonti tradizionali, era guidata da regole precise. A lui era vietato sia ricorrere a uno scritto, sia guardare al testo da tradurre; doveva infatti risultare inequivocabile la differenza tra la traduzione (che oggi chiameremmo consecutiva) e l’originale. Questa preoccupazione trapela anche da una massima rabbinica, apparentemente paralizzante: «Chi traduce in modo assolutamente letterale è un falsificatore, chi aggiunge qualcosa è un blasfemo» (Toseftà, Meghillah, 4,41). Ogni versione deve sapersi «altro», cioè commento e non sostituzione del testo sacro.
Accogliere la parola di Dio
Sulle pagine di questa rivista (cf. Regno-att. 8,2025,202ss), Luca Mazzinghi iniziava la sua presentazione della recente Traduzione letteraria ecumenica (TLE) del Nuovo Testamento3 con queste parole: «La parola di Dio “è viva ed efficace” (Eb 4,12), ma chiede d’essere annunziata e accolta. Perché lo si possa fare, deve essere compresa; per questa ragione la parola di Dio è stata tradotta nelle lingue dei diversi popoli, a partire dalle traduzioni più antiche, come la Settanta e il Targum, la versione siriaca, la Vetus latina e quindi la Vulgata, per non parlare delle prime versioni copte, etiopi, armene, arabe…».
Nulla da eccepire, naturalmente; tuttavia per gli scritti raccolti nel Nuovo Testamento si può e si deve essere più radicali. Va sottolineato che questi ultimi citano spesso i libri ebraici, definiti da Luca «Mosè, Profeti e Salmi» (Lc 24,44), servendosi della traduzione greca dei Settanta (ogni tanto con varianti).
Ci si può domandare se per queste citazioni valga quanto si legge nel Prologo del Siracide, in considerazioni dirette, in prima battuta, allo scritto di Gesù Ben Sira ma valide, a più vasto raggio, anche per tutti i libri biblici: «Siete dunque invitati a farne la lettura con benevola attenzione e a essere indulgenti se, nonostante l’impegno posto nella traduzione, sembrerà che non siamo riusciti a rendere la forza di certe espressioni. Difatti le cose dette in ebraico non hanno la medesima forza quando vengono tradotte in un’altra lingua. E non solamente quest’opera, ma anche la stessa Legge e i Profeti e il resto dei libri nel testo originale conservano un vantaggio non piccolo».
Con una domanda, niente affatto retorica, ci si può chiedere se in ogni traduzione non sia insita una qualche forma d’impoverimento.
Per i cristiani c’è qualcosa di più. L’arte del tradurre non è chiamata in causa solo per le Scritture d’Israele. L’affermazione apparentemente paradossale «in principio c’era la traduzione» vale anche per i detti attribuiti al Signore Gesù. Siamo di fronte a una considerazione cultural-teologica decisiva ma troppo spesso trascurata. Nessuna delle parole pronunciate da Gesù, siano o non siano ritenute ipsissima verba, ci è giunta nella lingua in cui fu originariamente pronunciata. Il figlio di Maria non parlava il greco della koine.
La caratteristica secondo cui le «parole prime» ci giungono in una lingua diversa da quella in cui furono pronunciate è inimmaginabile all’interno di altre tradizioni religiose. Nessun hadith di Muhammad sarebbe garantito se non fosse trasmesso in arabo. Per essere genuini i detti del profeta dell’islam devono conformarsi a due condizioni: dipendere da una catena valida e attendibile di trasmettitori ed essere formulati in arabo classico.
Inoltre i detti di Muhammad, per quanto assai autorevoli in ambito sunnita, hanno un valore inferiore rispetto a quello eccelso e inimitabile del sacro Corano. La situazione è assai diversa nel caso del cristianesimo: i Vangeli, compresi i quattro diventati canonici, comunicano infatti in larga misura il loro messaggio attraverso detti attribuiti a Gesù.
Secondo la Dei Verbum (cf. n. 7: EV 1/880s) uno dei principi cardine della tradizione sta nel fatto che gli apostoli «trasmisero ciò che avevano ricevuto dalla bocca del Signore»; la costituzione conciliare non fa alcun cenno al ruolo della traduzione, tuttavia esso s’impone di per sé.
La traduzione come ponte
Tradurre significa cercare di mediare tra il testo originario e la lingua dei destinatari. Si tratta di costruire un ponte in grado di collegare le due rive di un fiume non di rado assai largo. Ci si trova di fronte a un processo culturale in cui il punto d’arrivo non è meno qualificante di quello di partenza. Luca Mazzinghi, nella presentazione della TLE, ricorda che, secondo quanto riferito dal pastore Mathesius, quando traduceva il Levitico, Lutero consultò più volte il macellaio di Wittenberg al fine di rendere in tedesco i termini ebraici relativi ai vari pezzi di carne.
Scavalcando la testimonianza altrui, è dato risalire ad alcune parole dello stesso riformatore. Si tratta di due brevi passi dell’Epistola sull’arte del tradurre; il primo appare vicino, per così dire, allo spirito della Bibbia nota come TILC (Traduzione italiana in lingua corrente), il secondo è invece più prossimo alle scelte compiute dall’attuale TLE: «Non si deve chiedere alle lettere della lingua latina come si ha da parlare in tedesco (…) ma si deve domandarlo alla madre in casa, ai ragazzi in strada, al popolano al mercato e si deve guardare la loro bocca per sapere come parlano e quindi tradurre in modo conforme. Allora comprendono e si accorgono che parliamo con loro in tedesco».4 «Ma ho preferito scostarmi dall’uso corrente della lingua tedesca piuttosto che allontanarmi dal testo. Ah, tradurre non è un’arte fatta per tutti…».5
In conclusione, le traduzioni per loro natura sono sempre più o meno fedeli all’originale; tuttavia per i cristiani tradurre la Bibbia rimane comunque un’opera fedele; anzi, è concesso d’alzare il tono: tradurre costituisce una manifestazione di fedeltà nei confronti della propria stessa origine.
1 Il testo riprende e amplifica l’intervento svolto a Firenze il 21 maggio scorso in occasione della presentazione della Traduzione letteraria ecumenica del Nuovo Testamento organizzata dalla Società biblica in Italia, in collaborazione con Biblia.
2 Decreto sull’edizione Vulgata della Bibbia e sul modo di interpretare la sacra Scrittura, Sessione 4a, 8 aprile 1546.
3 Nuovo Testamento. Traduzione letteraria ecumenica, Società Biblica in Italia – Elledici, Roma – Firenze 2025.
4 Epistola sull’arte del tradurre e sull’intercessione dei santi», in Scritti religiosi di Martino Lutero, a cura di V. Vinay, UTET, Torino 1967, 708.
5 Ivi, 712.