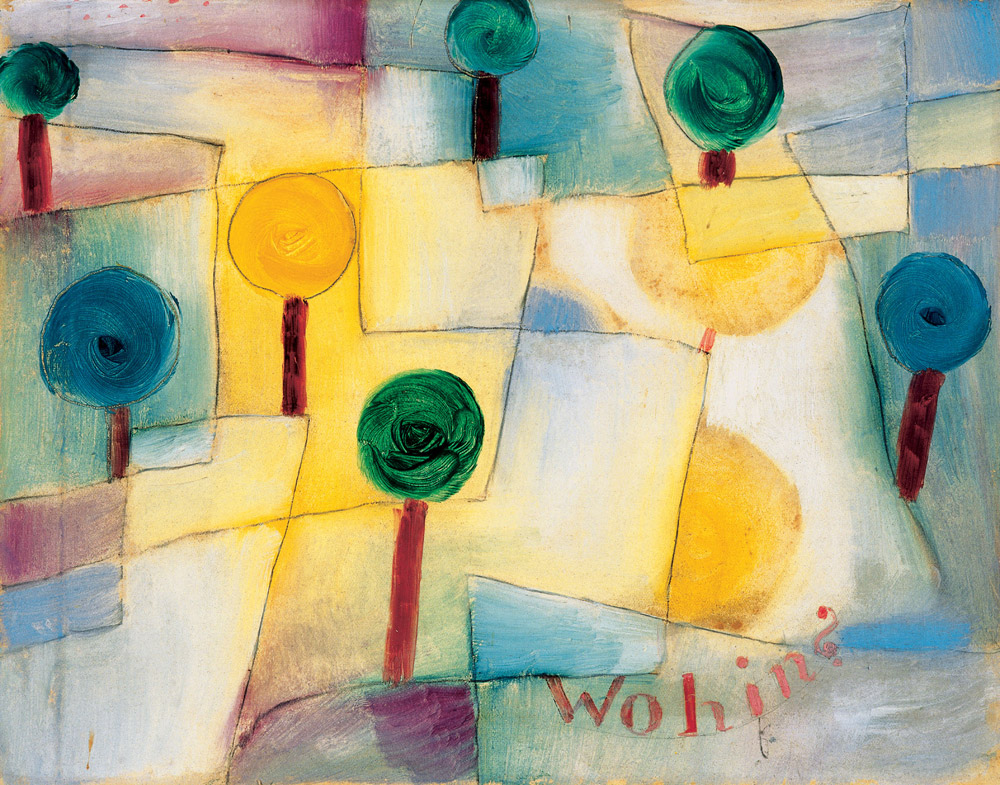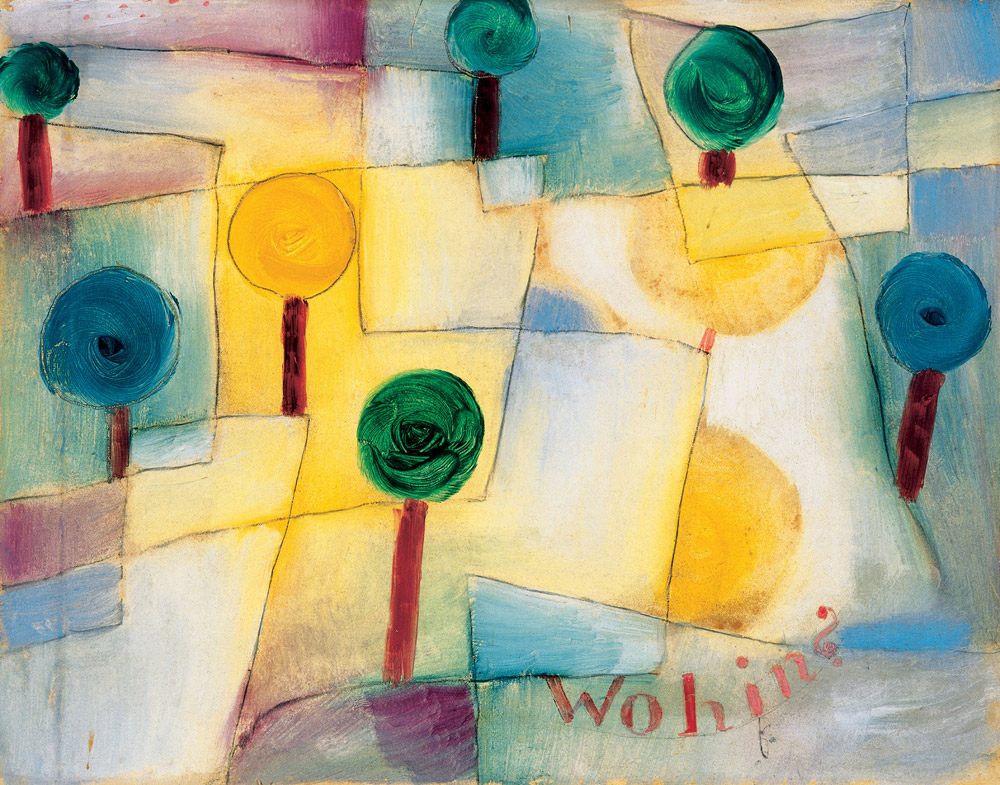Conservare la novità: un paradosso della storia cristiana
Un paradosso della storia cristiana
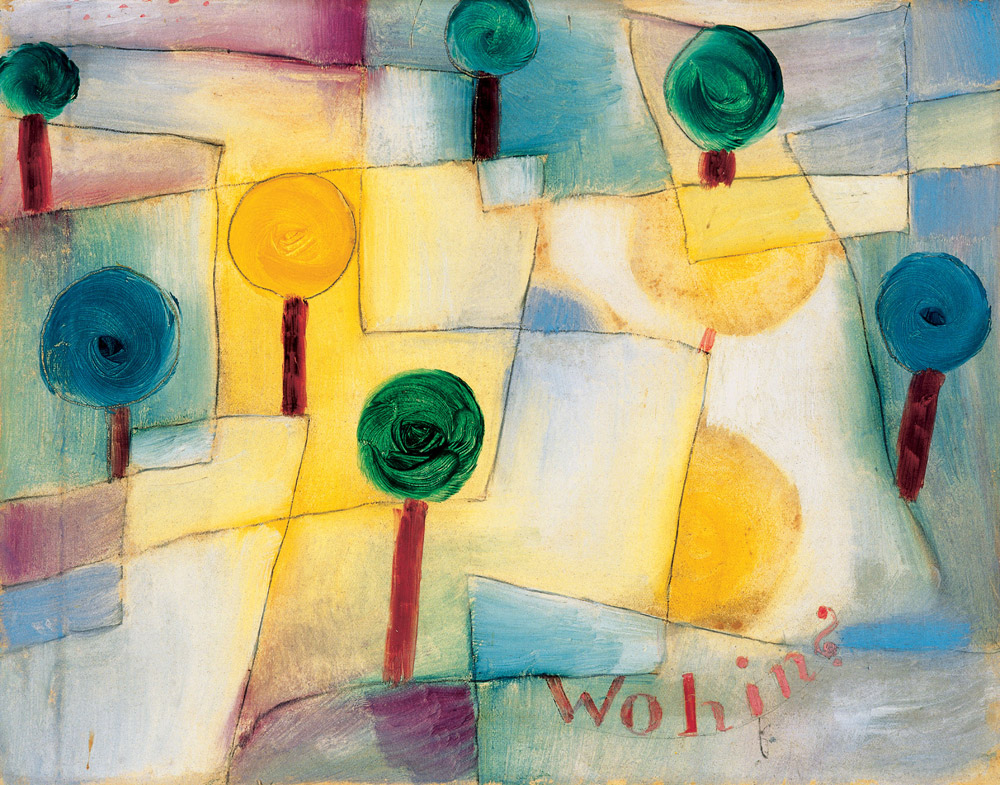
Nel Vangelo di Matteo, Giovanni Battista, ormai incarcerato, affida ai suoi discepoli un interrogativo da far giungere a Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» (Mt 11,3). Lungi dall’aver assistito al giudizio sugli empi da lui annunciato (cf. Mt 4,7-12), è il giusto Giovanni a essere perseguitato. Il dubbio nasce da una condizione personale che ne riflette una generale, nella quale domina un potere iniquo.
La risposta di Gesù non è né un sì, né un no. Le sue parole propongono, accanto al fatto che i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i morti risorgono, l’atto che ricapitola tutta la sua missione: «Ai poveri è annunciato il Vangelo» (Mt 11,5; cf. Is 61,1). Il buon annuncio dato ai poveri è un Vangelo povero. Gesù risana coloro che incontra senza mutare il corso del mondo. Per credere all’Evangelo occorre affidarsi a questa sperequazione.
Il brano prosegue con le parole su Giovanni; Gesù afferma che è il più grande tra i nati di donna, che è lui l’Elia che deve venire, ma aggiunge anche che il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui (cf. Mt 11,7-15). Segue il severo giudizio riservato alla sua generazione, concluso con un inatteso riferimento alla sapienza: «A che posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto”. È venuto Giovanni che non mangia e non beve, e dicono: “È indemoniato”. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e peccatori”. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie» (Mt 11,16-19).
Il paragone viene compreso se si parte dalla descrizione di un gioco di ruolo. La situazione è la seguente: un gruppo di bimbi indica ad altri un comportamento da assumere; se suonano, devono rallegrarsi, se si lamentano, essere affranti. Gli ordini, però, non sono eseguiti e i bambini ci restano male. Il paragone, in effetti, appare sbilanciato; nel caso di Gesù è formulato un giudizio senza che ci sia stato alcun ordine. Nella situazione concreta, il discorso va capovolto: sono i comportamenti del «digiunatore» e del «beone» che avrebbero dovuto far mutare l’atteggiamento di chi era seduto e stava a guardare.
Il rimprovero non riguarda solo i contemporanei di Gesù; tocca da vicino anche noi. Siamo una generazione eminentemente di spettatori che guardano e accusano (almeno implicitamente) coloro che con i loro comportamenti, o addirittura con il loro stesso esserci, ci turbano. Lungi dal prestare loro ascolto, sosteniamo che ci debbano lasciare in pace. Né la via di Giovanni, né quella di Gesù hanno convertito la loro generazione.
Otri vecchi, otri nuovi
Hanno fallito sia il giudizio, sia la misericordia. Eppure «la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie». Quali? Sono le opere enumerate all’inizio del capitolo e riassunte nell’Evangelo annunciato ai poveri? Tutto lascia credere che sia così. Si potrebbe anche concludere che l’ascolto dell’Evangelo esige, tanto allora quanto ora, di dare spazio a una sapienza operosa propria di spettatori che si lasciano scuotere dalla buona notizia e non restano insensibili neppure alle notizie di avvenimenti tristi o lieti (cf. Rm 12,15). Colto sotto questa angolatura, «l’andate e annunciate1 a Giovanni» vale anche per noi.
Il discorso sul «mangione e beone» (accusa particolarmente grave se si tiene conto di un sottotesto biblico; cf. Dt 21,20) va collegato a un episodio precedente. Gesù è a tavola con pubblicani e peccatori, i farisei ne chiedono la ragione ai discepoli; alla domanda risponde Gesù in persona affermando che sono i malati e non i sani ad aver bisogno del medico; occorre, quindi, apprendere il significato del detto profetico secondo cui il Signore vuole la misericordia e non già il sacrificio (cf. Os 6,6); egli, infatti, è venuto a chiamare non i giusti ma i peccatori (Mt 9,10-13).
La convivialità riconciliante suscita problemi anche ai discepoli di Giovanni, che pongono la domanda perché sia loro sia i farisei digiunano, mentre i discepoli di Gesù non lo fanno. Ed ecco la risposta: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l’uno e gli altri si conservano» (Mt 9,15-17).
Il primo detto sembra presupporre l’espressione colloquiale «metterci una pezza». Leggendo il passo, per così dire, a rovescio, si dovrebbe concludere che perché il rattoppo, sia pur provvisoriamente, funzioni, bisogna che il vecchio si incontri con il vecchio. Il logoro è rappezzabile soltanto con una realtà a propria volta non nuova. È una linea di condotta che esprime la politica degli avveduti conservatori di un tempo, i quali governavano in base alla massima secondo cui le oculate riforme scongiuravano le rivoluzioni.
È chiaro però che il Vangelo intende altro: quello che gli sta davvero a cuore è la prospettiva che esige per il vino nuovo otri nuovi. In Marco (2,22) si legge semplicemente la netta massima appena riportata; Matteo aggiunge invece una chiosa dalla portata non secondaria: «E così l’uno e gli altri si conservano».
Si dischiude il compito, dal suono ossimorico, di conservare la novità. Che sia una realtà permeata da qualche forma d’inevitabile contraddizione è dimostrato da tutta la storia cristiana. La novità da annunciare è custodita in otri che, a poco a poco, diventano, inevitabilmente, vecchi. È un problema avvertito, non a caso, già da Luca, che, dopo aver riportato il detto sugli otri nuovi, chiosa: «Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: “Il vecchio è gradevole”» (Lc 5,39). Valutazione che trova corrispondenza nell’apocrifo Vangelo di Tommaso (n. 47): «Nessuno beve del vino vecchio e desidera subito del vino nuovo».2
La responsabilità individuale della novità evangelica
L’irrisolta tensione tra nuovo e vecchio (e viceversa) percorre tutta la vicenda della fede cristiana. Un’enciclica (già celebre e negli ultimi tempi diventata ancor più famosa), in relazione alla politica e all’economia, lo ammetteva fin dal suo incipit: «Rerum novarum semel excitata cupidine, quae diu quidem commovet civitates…». Molto tempo prima e su tutt’altro piano, Matteo, in un passaggio che lascia trasparire qualche accento autobiografico, lo affermava in chiusura di una serie di parabole dedicate al Regno: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52).
Tirar fuori il nuovo dall’antico è paradossale ma, di certo, più fecondo di quanto non sia conservare la novità. In ogni caso, quest’ultima è un’operazione esposta al rischio di fallire. La sentenza matteana è posta a commento delle cosiddette parabole del Regno, che sono anche, soprattutto la prima, parabole sulla parola che annuncia il Regno.
Il capitolo si apre parlando del seminatore (cf. Mt 13,1-9.18-23) che getta il proprio seme su vari tipi di terreno ricavando un frutto corrispondente al fatto che la semente cada sulla strada, tra i sassi e i rovi o sul terreno fertile. Anche qui il paragone è meglio compreso se capovolto: non è il tipo di terreno a determinare l’ascolto, è il modo d’ascoltare a trasformarsi nelle varie forme di terreno.
Essere strada, sassi, rovi o terra buona dipende da noi. È un esito, non un presupposto. Tranne che nel caso estremo della strada, in tutti gli altri esempi si tratta di un processo. Quel che avverrà non è noto fin dal principio. La crescita può aver inizio ma poi arrestarsi. La responsabilità è chiamata in causa proprio in questo snodo.
Custodire la novità può condurre a esaurirla, a farle assumere l’aspetto di spighe rinsecchite o soffocate. Oggi un simile esito sembra, per molti aspetti, prossimo. Nel Vangelo di Tommaso vi è una parabola sorprendente: «Gesù disse: “Il regno del Padre è simile a una donna che recava una brocca piena di farina. Mentre camminava per strada lungi da casa, si ruppe l’ansa della brocca e la farina fuoruscì sulla via; lei non se ne accorse e non badò all’incidente. Giunta a casa sua posò la brocca e la trovò vuota”» (n. 97).
Non è seme, è farina da cui non germoglia nulla e che, una volta dispersa, non può essere neppure impastata e fatta lievitare (cf. Mt 13,33; Vangelo di Tommaso, n. 96). Il suo cadere lascia però una traccia. Per un po’ lungo il percorso qualcosa ancora si vede. Vi è tuttora memoria della novità evangelica. Il tempo di Pollicino non si è ancora estinto; tuttavia esso, per definizione, non dura per sempre.
1 In Mt 11,4 il testo greco ricorre al verbo anghello, «annunciare», che corrisponde a «ai poveri è annunciato il Vangelo» di Mt 11,5.
2 cf. L. Moraldi (a cura di), I Vangeli gnostici. Vangeli di Tomaso, Maria, Verità, Filippo, Adelphi, Milano1984.